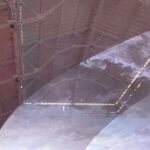Fin dai tempi di Dante Alighieri, è esempre esistita una ammirazione dei popoli nordici per quello che sarebbe poi stato chiamato il Bel Paese. Tracce di tale «[…] stupore dei“barbari” di fronte agli edifici grandiosi di Roma» sono presenti nel trentunesimo canto del Paradiso di Dante, a cui fa seguito Wilhelm Müller che imputa alla lirica il compito di descrivere la «Sehnsucht per la bella penisola esperia», ovvero “il desiderio nostalgico” che il Bel Paese suscita nei poeti nordici. Si tratta in parte di un ideale stereotipato, evocato in parte, dalle opere del Canova (Vivetta Vivarelli in Meli p.4).
Tra le liriche scritte da Goethe che evocano la sua nostalgia per l’Italia, vi è la V Elegia, facente parte delle Elegie romane (composte e pubblicate originariamente con il titolo Erotica Romana, tra il 1788 ed il 1790), analizzata da Meli in Il marmo, la fontana, il precipizio: Poesie tedesche sull’Italia per Le Lettere (2012) e da Claudio Groff (1944-2019).
(La curatrice del volume integrale per Feltrinelli è Paola Capriolo in J.W. Goethe: Poesie erotiche per Feltrinelli, 2021 per i lettori che fossero interessati).
La Quinta Elegia
Lieto d’estasi mi sento adesso su classico suolo,
più forte mi parla e m’attrae il mondo di ieri, di oggi.
Seguo il consiglio, con mano operosa sfoglio di giorno
le opere degli antichi con nuovo piacere.
Però mi tiene Amore occupato diversamente la notte,
Imparo a metà, e sono doppiamente felice.
E non imparo forse, le forme scrutando
dell’incantevole seno, guidando la mano sui fianchi?
Ben comprendo ora il marmo: penso e confronto,
Vedo con occhio che sente, sento con mano che vede.
Se l’amata mi toglie alcune ore del giorno,
ne rende in cambio altre della notte.
Non sempre baci, a volte son soltanto saggi discorsi;
se la coglie il sonno, io veglio, e penso… e penso…
Spesso ho creato già liriche tra le sue braccia
e piano ho scandito con le dita della mano
esametri sul suo dorso. Lei respira incantata di sonno,
arde il suo soffio fin nel profondo del mio cuore.
Ravviva Amore la fiamma, e pensa a quei tempi
quando ai suoi Triumviri prestava lo stesso servizio.
(Da Meli, p. 45)
In questa elegia, è rappresentato il bisogno di Goethe di staccarsi da temi e formalismi contenutistici delle elegie classiche: Goethe predilige una narrazione in prima persona accostata ad esperienze di vita reale; propone una più moderna concezione della realtà pur utilizzando schemi e modelli classici, nel rispetto della tradizione (Meli pp. 46-47). Temi principali presenti nella V Elegia sono la rinnovata unità armonica del mondo antico e (per Goethe) contemporaneo (V. 1), e la felicità del poeta ispirato (V. 2). La creazione dell’opera d’arte diventa un atto libero e gioioso, assimilabile ai piaceri secolari dell’atto amoroso, come circa centoventi anni più tardi ricorderà Rainer Maria Rilke dedicando idealmente a Goethe una poesia dallo stesso titolo, ma contenutisticamente molto diversa, quasi più divina che secolare.
I riferimenti agli antichi (in particolare Orazio e Ovidio) non mancano: secondo Orazio, durante il giorno si dovrebbero studiare gli antichi; Goethe sfoglia di giorno le opere degli antichi e, in maniera complementare, di notte il corpo dell’amata (v. 10), che può fungere da supporto per la stesura dei suoi esametri (v. 9). Vi è quasi una percezione pigmalionica dell’atto fisico, ritenuto in grado di trasformare la prestazione dell’artista da mera imitazione settecentesca di modelli ispirati a statue classiche in confronto vitale, creativo e fecondo tra antichità e contemporaneità (Meli p. 48).
Se l’atteggiamento elegiaco viene descritto dallo stesso Goethe come dolore collettivo e lamento di una realtà ormai irrimediabilmente perduta, le Elegie romane costituiscono un esempio di quella «soave bellezza» («schmelzende Schönheit») che rimane secondo Schiller uno dei cardini dell’appercezione del Bello (Schiller in Meli p. 51).
Circa 120 anni più tardi Rainer Maria Rilke, dedicherà idealente a Goethe una poesia con lo stesso titolo, ma molto diversa nel contenuto, quasi più divina che secolare. Nella Quinta Elegia di Rilke, scritta presumibilmente a Duino ma ultimata a Muzot (Svizzera) nel 1922 e disponibile in traduzione italiana dagli anni '40, i riferimenti a Goethe sono vaghi ma significativi: oltre al titolo di stampo goethiano viene evocata già dai primi versi la figura del viandante, presente tra le pubblicazioni dello stesso Goethe. Secondo traduzione e commento di Mario Amato, Rilke spiegherebbe in questa prima strofa il concetto di Sehnsucht e, citando sia l’opera d’arte Viandante dinanzi ad un mare di nebbia di Caspar David Friedrich che il testo Storia della letteratura tedesca di Ladislao Mittner, si evincerebbe che tale concetto non sarebbe pienamente traducibile con il termine ‘nostalgia’, in quanto struggimento privo di luogo, persona, tempo od oggetto di riferimento. Intrinseca nella strofa è la caducità del viandante, in quanto essere umano che, pur assoggettato alla Sehnsucht, non è in grado di capire il senso della vita.
Nela seconda strofa, ci si riferisce all’artista come decadente o incapace di accettare il cambiamento di ruolo dovuto all’invecchiamento fisico, che lo ha obbligato a passare da atletico circense a suonatore di tamburo.
Qui: l’appassito, rugoso atleta,
il vecchio, che ancora suona solo il tamburo,
entrato nella sua possente pelle, come se essa
avesse prima contenuto due uomini, ed uno
riposasse ora già nel chiostro di una chiesa, ed l’altro gli sopravvivesse,
sordo e talvolta un po’ confuso
nella orbata pelle.
La condizione dell’artista è mutata, così come quella del poeta: ora il poeta, un tempo possente, cinto di alloro, riconosciuto e tenuto in alta considerazione, sembra un vecchio circense regredito al ruolo di suonatore di tamburo. Pur cercando di recuperare il suo posto nella società, l’antica memoria rende al poeta il compito difficoltoso.
Nella terza strofa Rilke si riferisce alle stagioni e all’artista (‘l’acrobata’ secondo Mario Guardini, citato da Mario Amato) come fautore del processo creativo, quest’ultimo traente origine dall’anima o, più precisamente, dalla psiche.
Da questa ultima riflessione si può arrivare direttamente all’interpretazione delle ultime strofe del componimento, in cui vi è avvenuta separazione tra uomo e mondo. La poesia non nasce più dal rapporto con la natura, ma dalla psiche, dal metafisico. Rilke ripropone la figura degli amanti, più vicini a cogliere l’essenza del mondo e della trascendenza, spettatori di questo segreto che può essere soltanto accennato o taciuto.
Si può quindi affermare che tra la V Elegia romana di Goethe e la Quinta Elegia duinese di Rilke ci sia affinità contenutistica per quanto riguarda la figura del poeta. Ciononostante, mentre la V Elegia di Goethe punta sul vigore intellettuale e fisico del poeta («Seguo il consiglio, con mano operosa sfoglio di giorno // le opere degli antichi con nuovo piacere. // Pero mi tiene Amore occupato diversamente la notte, // Imparo a metà, e sono doppiamente felice.») in cui si conferisce all’atto fisico un ruolo creativo, il componimento di Rilke punta sulla caducità dell’essere umano (o sulle mancanze prestazionali andrologiche del poeta: «Qui: l’appassito, rugoso atleta, // il vecchio, che ancora suona solo il tamburo») e si conferisce al poeta il ruolo di comunicatore metafisico, lasciando agli amanti quello di cogliere l’essenza del mondo.
Fonte: