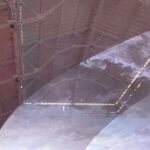Nel pensiero di Platone, la bugia non è un dettaglio secondario ma una vera e propria contraffazione della verità. Mentire significa produrre un discorso che prende l’apparenza del vero pur non possedendolo, come un falsario che batte una moneta falsa per farla sembrare autentica.
Platone distingue due forme di menzogna: quella nell’anima, più grave, che consiste nel credere intimamente al falso e quindi corrompere la propria interiorità, e quella nelle parole, che consiste nel far credere il falso agli altri. Entrambe appartengono al regno della mimesi ingannevole (imitazione), delle copie apparenti che deformano la realtà.
In questo senso la bugia non è solo un atto di inganno ma una condizione che colloca l’uomo dalla parte delle ombre, dei simulacri, delle immagini che pretendono di sostituirsi all’essere. È vero che Platone, nella Repubblica, ammette l’eccezione della “nobile menzogna”, ossia un racconto inventato capace di rafforzare l’ordine sociale ed educare la città, ma resta fermo che il falso, pur potendo servire in via subordinata, non possiede mai un valore autonomo. Solo la verità guida davvero verso il bene e la conoscenza, mentre la menzogna è sempre una maschera fragile.
Questa riflessione antica acquista nuova luce se la si mette a confronto con un episodio cruciale della modernità letteraria: la pubblicazione de L’amante di Lady Chatterley di D. H. Lawrence. Uscito clandestinamente nel 1928 e al centro di censure e processi fino agli anni Sessanta, questo romanzo fu accusato di oscenità e definito dalla stampa “il più indecente della storia della letteratura inglese”.
Eppure, dietro lo scandalo, la forza del libro stava proprio nella sua capacità di denunciare la contraffazione diffusa nei rapporti sociali e affettivi della società vittoriana. Lawrence, raccontando la relazione tra una nobildonna e un guardiacaccia, sfidava le convenzioni di un mondo fondato sull’ipocrisia, sulla distanza di classe e sulla morale che mascherava la verità dei desideri umani. La sua protagonista, Lady Chatterley, si ribella a un matrimonio ormai ridotto a una copia vuota, a un rapporto coniugale che non è più autentico ma contraffatto, e cerca altrove una vita fatta di tenerezza e di pienezza sensuale. In questo senso il romanzo, con la sua prosa provocante, non è solo un atto di scandalo ma una denuncia della falsificazione dei legami, una sfida a una società che si regge su rapporti artefatti e soffocanti. E qui emerge una riflessione ulteriore: la contraffazione dei sentimenti in una relazione, con la conseguente mutazione dei valori, può essere considerata anche come una copertura dell’istinto predatorio e dell’esercizio del potere sull’altro.
Dietro i legami che si presentano come amore o dedizione può nascondersi infatti una dinamica di dominio, un uso dell’altro come oggetto, una forma di menzogna che non riguarda solo le parole ma la vita stessa.
In fondo Platone aveva già messo in guardia da un eros che non eleva ma domina, che non conduce l’anima alla contemplazione del bello e del bene ma la trascina verso il possesso e l’assoggettamento. Quando il sentimento si contraffà e si muta in una maschera, esso diventa un’arma per esercitare potere, non più un ponte verso l’altro. Anche la storia editoriale del libro può essere letta in questa chiave: prima censurato e nascosto, poi trasformato da un processo in un clamoroso caso editoriale, Lady Chatterley mostra come persino la diffusione di un’opera possa attraversare fasi di contraffazione, in cui ciò che è vietato diventa improvvisamente legittimo e addirittura celebrato.
Così, dall’antica Grecia alla letteratura del Novecento, il tema della bugia e della contraffazione si rivela centrale: per Platone riguarda l’anima e il linguaggio, per Lawrence la società e i rapporti umani, ma in entrambi i casi emerge la stessa tensione tra ciò che è autentico e ciò che è mascherato. Cercare la verità, che sia nella filosofia o nell’arte, significa allora smascherare le copie ingannevoli, rifiutare la menzogna e la contraffazione che deformano la vita, e aprirsi alla possibilità di un’esistenza fondata sulla realtà, sulla sincerità e sulla libertà.