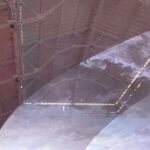Samuel Beckett è protagonista assoluto del teatro dell’assurdo, movimento novecentesco che ha sovvertito le regole drammaturgiche tradizionali per interrogarsi sull’essenza dell’esistenza umana.
Nato a Dublino nel 1906, dopo la laurea al Trinity College in lingue e letterature moderne si avvicina al pensiero di Dante, Racine e Proust.
Il legame con la filosofia è altrettanto significativo, l’autore studierà infatti il pensiero di Cartesio e Spinoza, mostrando interesse per il pessimismo filosofico di Schopenhauer e le idee esistenzialiste di Kierkegaard. Tuttavia, ha sempre cercato di rompere gli schemi letterari. Il capolavoro “Waiting for Godot”, in italiano "Aspettando Godot", del 1953, ne è un esempio.
Il teatro dell’assurdo si caratterizza per la rappresentazione della condizione umana come priva di sostanza e per l’utilizzo di dialoghi senza raziocinio apparente, caratteristica che lascia spazio a molte domande. In "Waiting for Godot”, i protagonisti, Vladimir ed Estragon, attendono invano un misterioso personaggio, il cui arrivo è continuamente posticipato.
La trama diventa l’opportunità per esplorare temi esistenziali come il tempo, l’indugio e l’alienazione.
Le reazioni della critica sono state differenti: da un lato, c’è chi celebra la capacità dell’opera di mettere a nudo le fragilità umane, dall’altro chi critica questo modo di dire senza spiegare.
L’opera è stata definita una delle più grandi tragedie comiche mai scritte da critici come Martin Esslin, che nel suo saggio “The Theatre of the Absurd”, (Il Teatro dell'Assurdo) ne ha riconosciuto l’importanza storica e artistica.
Alcuni accusano Beckett di comunicare a pochi. “Waiting for Godot” è stato definito un esempio di “teatralismo sterile” da chi vede nella mancanza di azione un limite insormontabile.
Pur essendo un’opera atemporale, è radicata nel dopoguerra.
La rappresentazione di individui marginalizzati, senza fissa dimora né identità stabile, rispecchia le esperienze degli sfollati e Beckett stesso spiega più volte che il suo lavoro non può ignorare la condizione umana che lo circonda.
Ad oggi, dove disuguaglianze sociali e crisi globali continuano a generare sentimenti di alienazione, l’opera è decisamente attuale.
Come sottolinea il filosofo Theodor Adorno, Beckett insegna che l’umanità può sopravvivere solo aggrappandosi all’assurdo, invitandoci a riflettere su questioni come il senso dell’esistenza e l’assurdità della vita.
In un’epoca di crisi esistenziale e sociale, il suo teatro ci ricorda che siamo comunque costretti ad andare avanti. Samuel Beckett è sia drammaturgo dell’assurdo sia reporter della condizione umana: un interprete delle inquietudini e delle speranze. La sua opera è una testimonianza di resistenza, ricerca e libertà intellettuale.
In un mondo iperconnesso e ricco di stimoli, “Waiting for Godot” acquisisce nuove risonanze. L’incomunicabilità tra Vladimir ed Estragon richiama le difficoltà relazionali dell’era digitale, mentre l’attesa di Godot può essere letta come metafora delle speranze disilluse di progresso e stabilità.
I protagonisti dell’opera di Beckett rappresentano coloro che sono in fuga dalla guerra, dalla povertà e dalla crisi climatica. La mancanza di risposte definitive è un invito a confrontarsi con le domande più scomode di oggi.
Come dovremmo interpretare Beckett? Nel nostro tempo frenetico, la lentezza e l’indeterminatezza del teatro dell’assurdo hanno ancora spazio? O siamo troppo presi dalla ricerca di soluzioni pragmatiche per apprezzare il valore di un’attesa sprovvista di esito?
Non offre risposte, ma pone domande. È qui che risiede la forza del teatro di Beckett: nel costringere il pubblico a interrogarsi solo per sete di conoscenza, senza nemmeno bisogno di risposta.
Diventa l’artefice di una forma innovativa. Parole e gesti senza un chi e un perché. Beckett porta la sua narrativa che “non narra”, in francese, lingua per lui impersonale e neutra. Fino a che punto un’opera artistica può porre interrogativi senza alienare il pubblico?
“Non c’è nulla di più comico dell’infelicità.”, scrive Beckett. Eppure, possiamo davvero ridere di fronte all’angoscia esistenziale di “Waiting for Godot”?
Dovremmo forse leggere Beckett come un autore che denuncia l’alienazione dell’individuo in una società capitalista che ha perso ogni senso di comunità e solidarietà. In un’epoca segnata da disuguaglianze, questa interpretazione combacia con le difficoltà odierne e l’alienazione diventa decisamente attuale. Ma questa interpretazione regge? Oppure il teatro è incapace di proporre soluzioni?
Nel nostro mondo connesso ma alienante, forse l’attesa di Godot rispecchia un’umanità che continua a sperare e attendere silente. Ma chi è, davvero, Godot? E perché aspettarlo?
Nato per esprimere la perdita di senso della condizione umana, il teatro si presta perfettamente a un’analisi in chiave moderna. Incomunicabilità, attesa vana e assenza di un significato univoco si riflettono nella società di oggi. Nell’opera, i protagonisti si scambiano battute vuote, specchio di molte dinamiche politiche odierne. Il dibattito pubblico sui social, fatto di attacchi personali e disinformazione, somiglia a un dialogo “beckettiano”, tanto rumore senza sostanza, parliamo senza trovare soluzioni, senza ascoltare, insultiamo senza capire l’altro
I continui rinvii nelle risoluzioni su temi globali, come il cambiamento climatico, richiamano l’attesa di Godot, insomma, tutto questo si collega con l’attualità. Nonostante la retorica prometta soluzioni imminenti, il “Godot” della sostenibilità sembra non arrivare mai e più passa il tempo più si allontana la speranza del suo attracco.
Alienazione e dimissioni silenziose (quiet quitting)
L’alienazione denunciata da Beckett, inoltre, si collega con la condizione dell’individuo nella società iper-capitalista.
Le persone lavorano precariamente e senza tutele, mangiate dal consumismo e spesso si sentono come i protagonisti del teatro dell’assurdo, ossia, in balia di forze incontrollabili. Le dimissioni silenziose, fenomeno in cui i lavoratori fanno solo lo stretto necessario, rispecchiano il rifiuto di partecipare al progresso economico. È una forma di ribellione passiva, come quella dei personaggi beckettiani, di chi si adegua e si spegne senza nemmeno accorgersene. Il teatro dell’assurdo si nutre del nichilismo, della perdita di certezze assolute.
Le campagne politiche basate su fake news o narrazioni estremizzate, mostrano la mancanza di un punto di incontro. Proprio come con i personaggi dell’assurdo, che parlano senza capirsi.
Inoltre, l’iperconnessione tecnologica amplifica il paradosso dell’incomunicabilità. Siamo automi alla ricerca di attenzioni e ci sentiamo al centro del mondo solo quando sentiamo una notifica. Il teatro dell’assurdo prefigura questa dinamica, è quindi un precursore.
Il doomscrolling
Il fenomeno del doomscrolling (scorrere notizie negative sui social media senza sosta) rispecchia l’ossessiva ripetizione di azioni senza scopo, così presente nelle opere di Beckett, da sembrarci impossibile il non paragone. È una rappresentazione moderna dell’assurdità esistenziale, l’inutilità dei fatti. L’attesa di Godot è la metafora della speranza sociale, spesso vana. Aspettiamo cambiamenti strutturali che tardano ad arrivare, nonostante le promesse.
La pandemia di COVID-19 ci ha mostrato cosa significa attendere senza nessuna sicurezza un ritorno alla normalità. Questo arresto ha reso le dinamiche dell’assurdo ancora più tangibili; eravamo tutti lì a sperare nel cambiamento ma senza muoverci. Il teatro dell’assurdo rappresenta il vuoto esistenziale e le contraddizioni moderne.
Frammentazione sociale, alienazione capitalista, crisi comunicativa e attesa vana di un futuro migliore confermano la sua estrema attualità.
Oggi, il lavoro di Beckett invita a una riflessione profonda sull’essere umano come individuo e come parte della collettività. In un contesto di crisi climatica, tensioni geopolitiche e disuguaglianze crescenti, Beckett ci sfida a guardare oltre l’assurdo per trovare nuove forme di resilienza e solidarietà. Come dice Vladimir, “Non è ancora finita” (“It’s not over yet”).
Proprio nell’accettazione dell’assurdo risiede la chiave per costruire un futuro migliore.
Samuel Beckett è molto contemporaneo. Il testo sottolinea che l'assenza di risposte definitive porta a confrontarsi con problemi complessi senza scorciatoie.
La sua opera suggerisce che l'accettazione dell'assurdo può aprire la strada a nuove forme di speranza. La semplice decisione di Vladimir ed Estragon di “aspettare” implica una forma di resistenza contro l’assurdo. Il loro agire, si avvicina a ciò che Camus chiama il “gesto di vivere”. Un’accettazione del nonsenso che, paradossalmente, dà valore alla vita.
La scelta di continuare diventa un atto umano. Albert Camus e Samuel Beckett condividono una riflessione profonda sull'assurdità della condizione umana, ma le loro risposte filosofiche divergono significativamente. Camus vede nel gesto di vivere un atto di ribellione e significato; Beckett, invece, esplora la disperazione e l'immobilità.
In conclusione è essenziale dire che il teatro di Beckett non è solo una semplice opera artistica. Vladimir ed Estragon rappresentano una situazione simile a quella degli sfollati: senso dell'esistenza ed assurdità della vita portano ad alienazione dell'individuo, ovvero a perdita di certezze assolute. Non fornire soluzioni ai quesiti, parlare senza ascoltare o insultare senza capire l'altro sono atteggiamenti comuni nella società contemporanea che però suggeriscono di guardare oltre l’assurdo per trovare nuove forme di resilienza, facendo leva su ciò che di positivo si può umanamente ricavare dal susseguirsi di situazioni insensate.
Le sue opere ci sfidano a riflettere sul significato del tempo, delle relazioni e della resilienza umana. Beckett non offre soluzioni, ma ci invita a ragionare su questi elementi.
E allora esploriamo il nostro senso in questa vita ricca di non sense.