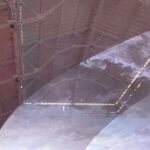“George Orwell, precursore dell’evoluzione della società moderna e archetipo del concetto di Grande Fratello”
Nel panorama della letteratura distopica, abbiamo un fautore dei tempi moderni. Con il suo discusso romanzo “1984”, George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair (1903-1950), fu uno scrittore, giornalista, saggista, attivista e critico letterario britannico. Pubblicato nel 1949, “1984” si presenta come una delle sue opere più emblematiche, incisive e radicali nel raccontare le derive totalitarie e l'oppressione delle libertà individuali. Un vero e proprio avvertimento del tutto premonitore, una visione in cui la società è governata dalla sorveglianza totale e dal controllo organizzato di pensieri e azioni dell’intera collettività.
Il concetto di “Grande Fratello”, centrale nell'opera, non descrive solo un leader angosciante e oppressivo, ma un simbolo evidente della perdita “sistemica” di autonomia personale. Le derivazioni politiche, sociali e tecnologiche di questa visione sono oggi più attuali che mai. Basti pensare alla crescente invasione della privacy e all'uso delle tecnologie (talvolta anche IA) per la sorveglianza globale. Il “Grande Fratello” in “1984” è il leader indiscusso del Partito, un'entità che esercita un controllo assoluto sul popolo, attraverso una sorveglianza costante e la manipolazione della realtà.
La frase celebre “Il Grande Fratello ti sta guardando” è diventata nel tempo l’emblema della sorveglianza governativa che non lascia scampo alla libertà. Nel mondo di Orwell, essendo la sorveglianza non un puro atto fisico ma un sistema che attraversa ogni aspetto della vita quotidiana, alla fine, tendiamo a rassegnarci come un soldato che depone le armi.
La continua osservazione diventa il mezzo attraverso cui il “regime” mantiene il controllo, sopprimendo la libertà di pensiero e la capacità di critica[1].
Scrisse Orwell: “Se si vuole mantenere il controllo sulla mente degli uomini, si deve prima dominarli fisicamente. In 1984 la distruzione della libertà è tanto fisica quanto psicologica”.
Questo passaggio sottolinea come, nella distopia orwelliana, la libertà sia distrutta a più livelli, lentamente e inesorabilmente. Il controllo fisico è il mezzo di punizione, nonché una forma di oppressione continua, endemica e quasi onnipresente, esercitato mediante la televisione a circuito chiuso (TVCC).
Corpi e pensieri sono sotto il controllo di qualcosa di esterno a noi, che sia un governo, una pubblicità, o un social, quasi sempre siamo l’immagine di ciò che vediamo.
Un controllo che non lascia spazio all'opposizione. Il panopticon orwelliano è divenuto un concetto sempre più rilevante nella società moderna, dove la raccolta dei dati diventa oppressione psicologica.
La visione orwelliana della sorveglianza ha trovato una corrispondenza preoccupante con le tecnologie moderne. La crescente invasione della privacy attraverso il monitoraggio digitale è divenuta una realtà quotidiana, sia quando la sorveglianza è attuata dai governi sia quando lo è da giganti tecnologici come Google, Facebook, Amazon, i quali monitorano le nostre attività online e offline[2]. Il fenomeno da concetto astratto è ormai una prassi che manipola le scelte politiche e sociali. Una volta accettato un qualsiasi cookie da un qualsiasi sito, i nostri dati sono prelevati da siti internet dubbi, da filtri commerciali per inondarci di spam e monitorare le nostre preferenze.
L'analisi dei dati può alterare la percezione che abbiamo di noi stessi, dei nostri comportamenti e delle nostre decisioni, se ogni giorno ci sentiamo dire di acquistare un determinato prodotto, probabilmente verremo subliminarmente convinti all’acquisto.
Come peggiorerà la nostra esistenza se non compriamo un dato prodotto? Il punto, purtroppo, non è quanto peggiorerebbe realmente, ma quanto veniamo convinti dall’algoritmo
Il concetto di “grande fratello” si è esteso alle pratiche quotidiane della nostra vita online, dove le aziende e le istituzioni governative sembrano “guardare” raccogliendo dati che definiscono e manipolano le nostre esperienze digitali. Non solo, siamo anche consapevoli di questo processo, ma inevitabilmente lo accettiamo, senza alcuna alternativa possibile.
I dati raccolti dai social servono per creare “bolle di filtro” nelle quali gli utenti sono costantemente esposti a contenuti che rafforzano preesistenti credenze e pregiudizi, escludendo qualsiasi punto di vista divergente.
Come nel romanzo di Orwell, dove la verità è manipolata dal Partito attraverso il Ministero della Verità, oggi la realtà è soggetta a distorsioni in tempo reale attraverso media e tecnologie digitali; la potenza dei social e dei motori di ricerca, implica che le notizie vengano curate da algoritmi che selezionano quali contenuti saranno visibili all'utente.
Oggi, la visione di Orwell è diventata una riflessione sul presente. La “sorveglianza totale” passa da concetto teorico di un regime dittatoriale a realtà quotidiana, creando una nuova forma di controllo. Se la nostra sorveglianza fosse come nel romanzo, costante e onnipresente, saremmo forse in grado di riconoscere i limiti della nostra libertà? È questa la domanda centrale a cui dobbiamo rispondere, poiché la sorveglianza in molte forme è già divenuta il nostro nuovo normale.
L'importanza della sorveglianza è alla base dell'idea di “vigilanza permanente” e di manipolazione linguistica che Orwell definisce Newspeak. La lingua stessa diventa strumento di controllo, dunque, un veicolo di conformità, in cui le parole non sono più capaci di esprimere la realtà nella sua totalità, divenendo suo malgrado limitativa e limitante.
Pur essendo “1984” un'opera scritta più di 70 anni fa, i temi trattati da Orwell appaiono incredibilmente moderni.
Social media, videocamere di sorveglianza in ogni angolo delle nostre strade, dalle applicazioni per il tracciamento dei dati. e raccolta di informazioni personali da parte delle grandi aziende creano una realtà non tanto distante da quella descritta nel romanzo.
Anche la sfera politica non è immune a questa invasione della privacy.
L'uso dei dati da parte dei governi per tracciare i comportamenti dei cittadini è un fenomeno che si sta espandendo, con la scusante della sicurezza nazionale e del contrasto al terrorismo. Meno libertà in cambio di più sicurezza è la promessa che spesso ci viene fatta, portandoci a compromessi che al momento stesso non ci sembrano pesare, non avendo motivo di preoccupazione. In realtà, nessuno dovrebbe toglierci qualcosa in cambio di un’altrettanta millantata forma di giustizia.
Le piattaforme sociali diventano il campo di battaglia in cui l’influenza e la propaganda vengono spacciate per notizie oggettive, destabilizzando le fondamenta della verità pubblica. La guerra dell’informazione è sia una battaglia di dati che di percezioni.
La lettura di 1984 è sia una denuncia della dittatura che un avvertimento sui pericoli di una società dominata dal la norma del controllo . Sebbene possa sembrare lontano dal mondo di oggi, Orwell ci ammoniva sul rischio di perdere la nostra libertà attraverso la tecnologia e la manipolazione. La sorveglianza, quindi, è tanto forma di protezione e sicurezza quanto minaccia insidiosa alla nostra libertà individuale.
Come ci ricorda Orwell, il prezzo del controllo è il sacrificio delle libertà fondamentali.
L’autore non si limitava a denunciare il totalitarismo ma colpiva ogni sistema di potere che perpetuava le disuguaglianze.
La giustizia sociale era per lui incompatibile con il controllo assoluto elitario di risorse e persone. Nell’attuale situazione di sorveglianza, i governi e le grandi corporazioni collaborano in nome del profitto. Tuttavia, la sua lezione non è solo denuncia: ma invito all’azione effettiva.
Ciò richiede una risposta collettiva. Dobbiamo ripensare il rapporto tra tecnologia e società, promuovendo strumenti digitali etici e accessibili a tutti. La consapevolezza diviene il primo passo per sfuggire al controllo; l’educazione digitale deve diventare parte integrante della nostra formazione, aiutando le persone a comprendere come vengono utilizzati i loro dati e a riconoscere i meccanismi di potere nascosti.
Orwell ci insegna che il potere non è mai invincibile e per opporci al “Grande Fratello” moderno dobbiamo organizzarci, costruire reti di solidarietà, proporre modelli alternativi che restituiscano dignità all’individuo, dignità quanto libertà reale: creando un’alternativa, si alimenta un dialogo costruttivo.
[1]Ricci, F. (2017). La simbolica del potere come simulacro e la menzogna dell'immaginario in 1984 di Orwell. Per una critica al totalitarismo. In Il comunismo nella storia del XX secolo. Politica, istituzioni, ideologie (Vol. 35, pp. 49-62). Edizioni Nuova Cultura.
[2]Lanier, J. (2014). La dignità ai tempi di internet. il Saggiatore.