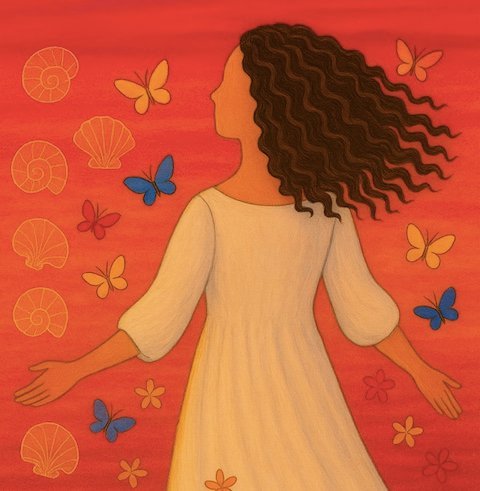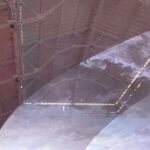Manifesto dell'amore
L'AMORE È CULTURA
Solo l’occidente ha concepito l’amore a fondamento delle relazioni umane
“Cos'è l'amore?”. La domanda tra evidenza e mistero, desta tante interrogazioni, convinzioni e incertezze.
Dalla mitologia alla religione, dalla filosofia alla psicologia, le variazioni sono numerose quanto infinite.
Afrodite, dea dell'amore e della bellezza, così come suo figlio Eros, evocano perlopiù degli amori carnali, e una certa incostanza, tra armonia e disordine.
L'etimologia, discussa, non rivela nulla di convincente, e non dissipa i paradossi che i vari significati del vocabolo racchiudono.
Generalmente ricollegata all'amore materno, eventualmente derivata da voci infantili rivolte alla mamma, la parola rimanda indifferentemente all'affetto, al desiderio, alla passione e ai cieli, senza contare l'espressione: “Amo fare...”, adatta a qualunque attività.
Sembra predominare il piacere, anch'esso declinabile secondo una moltitudine di riferimenti, dalla mente al cuore, dalla pelle ai sensi, ricorrendo a tanti stati d'animo immaginabili.
Lo scrittore svizzero Denis de Rougemont (“L'amore e l'Occidente”, 1938), riteneva l'amore mortifero, semplice concetto derivato dal cristianesimo, tesi che riprese in “Come te stesso”, sottotitolato “i miti dell'amore” (1961).
De Rougemont adopera un'argomentazione tutt'altra che convincente, per il fatto che cinesi, buddhisti e induisti non posseggono un vocabolo equivalente, ma molte parole per qualificare vari sentimenti che noi, chiamiamo senza differenziarli, amore.
L'inventiva dell'amore e le sue conseguenze relazionali e sociali vengono così ridotte a illusione dall'impatto culturale più fasullo che strutturante. Se in riferimento alle parole, la tesi è ammissibile, è totalmente dimenticare quel che sono le società indiana o cinese sociologicamente, riguardo tra l'altro al crollo del cemento familiare in Occidente, che contrasta con la vitalità di paesi come l'India o la Cina, ancora considerati, è vero, sottosviluppati ai suoi tempi. Il vocabolario non saprebbe nascondere le realtà demografiche, morali e culturali, che descrivono o meno.
Tristano non ama Isotta, Don Giovanni non ama nemmeno se stesso, e via dicendo.
È sconcertante negare l'amore riferendosi a un “non amore”, eppure, l'argomento sembra convincere.
L'Occidente avrebbe in realtà inventato l'amore, dato un valore ai nostri sentimenti e definito la loro realtà.
Il proposito è interessante, e contiene insomma un senso ben diverso da quello che consiste nel metterlo in dubbio.
Coniare concetti e valori fa proprio parte del modo in cui le civiltà si elaborano e sviluppano. È quindi rilevante che l'Occidente, e l'Occidente solo, abbia concepito l'amore quale fondamento delle relazioni umane, sia pure rivolgendolo alla religione, per aggiungere però: “Amerai il tuo prossimo come ami te stesso (“Levitico”), in un'interpretazione moderna.
L'idea secondo cui, i sentimenti, e dunque, la soggettività, è fonte di creazione, non è di certo da buttare.
Tra le proposte trascurate dall'etimologia, l'ipotesi che pretende che amore deriverebbe dall'espressione a mors, e comunque, chi potrebbe affermare che non possiamo “amare a morte”, ovvero fino al crimine, e in modo positivo, “cacciare la morte” tramite l'amore?
Che poi, l'amore richieda una fede, in altre parole, Dio, appunto perché ci priva del crederci onnipotenti, soltanto mortali, e per quel motivo, ci conduce ad associare amore e morte, non possiamo negarlo; appartiene ai fondamenti stessi delle nostre credenze ancestrali più ancorate.
A questo punto, ci rimane da definire l'amore, rompendo gli schemi, e non da ritenerlo un'illusione sorta dall'immaginazione, una rimanenza delle dottrine religiose, tanto meno che esse, se ne nutrono.
L'amore rispecchia il modo in cui, si abbandona l'essere centrato su se stesso che supera i propri limiti attraverso relazioni costruttive che concedono allo stesso individuo un divenire che non potrebbe mai raggiungere da solo, e allarga la sua visione del mondo e le sue azioni a una considerazione disinteressata e un riconoscimento dell'altro, nell'ambito di una dinamica sempre fluttuante.
Tale dinamica non può evitare di coinvolgere il soggetto in tutte le dimensioni del suo essere e nelle modalità della sua esistenza, corpo ed animo, inutile precisarlo, non senza profondi mutamenti che dalle emozioni e dal desiderio alle abitudini e ai comportamenti, sconvolgono tutta la persona.
L'amore disturba, sconvolge l'ordine stabilito ed erige le proprie regole senza mai fissarle definitivamente. L'amore richiede d'altronde di impegnarsi, un volontarismo che coniughi al tempo stesso le sollecitazioni del corpo e quelle della mente, gli obblighi della vita quotidiana e l'incostanza degli umori.
L'amore improvvisa di continuo, contrasta le rigidità dell'acquisito, del banale, dell'immobile.
L'amore così come l'estetica e la arti, si distingue per la sua creatività, per i segni con cui disegna il suo cammino sconosciuto.
L'amore è cultura, si coltiva, erige nuove strade, rispecchia la libertà per la sua inventiva e addirittura la democrazia per il suo altruismo.
Sia pure inafferrabile per natura e segreto come l'ignoto al quale tende, richiama l'autenticità
di esseri che si scoprono, cementa la convivialità e riunisce gli sconosciuti, apre un varco nelle mura più impenetrabili e accende una luce nell'opacità della routine.
Rinunciare all'amore è come abbandonare un patrimonio, cancellare ogni elaborazione passata, soffocare il senso della vita, e per concludere, rinnegare l'eredità lasciata dai defunti, e la continuità del loro operato, ravvivato dai ricordi.
Una società che spaccia l'amore come un prodotto di consumo o una promessa senza riscontro, riduce l'individuo e la comunità, a mere macchinerie che ripetono invariabilmente gli stessi passi su uno stesso cammino cieco, senza né etica, né progetto, soddisfazioni immediate e oblio istantaneo. Voltare pagina, un'altra pagina e un'altra ancora, sulle quali verrà scritta una continua storia sviscerata, colma di artifici e sembianze.
L'amore è sostanza, materia viva, appartenenza, rivelazione.