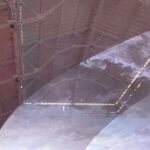Nel lontano 1982, Ida Magli, figura cardinale dell'antropologia culturale italiana, scriveva in ‘La femmina dell'uomo’:
«Il dialogo fra l'uomo e la donna è perduto per sempre secondo Lévi-Strauss, ma forse sarebbe più corretto dire che questo dialogo, non vi è mai stato; l'uomo ha parlato solo con se stesso, nella foresta di segni che ha creato, e da questa solitudine ha tratto il senso della sua esistenza».
La solitudine, tema di cui si parla malvolentieri, fra percentuale di anziani nella popolazione, coppie separate, famiglie dette monoparentali, e precarietà, risulta ormai un fenomeno diffuso, in continuo aumento negli ultimi anni secondo gli istituti di sondaggi.
Oltre alla povertà e al rischio di esclusione sociale, le cause da cui deriva la solitudine scaturiscono, ciascuno di noi ne ha fatto esperienza durante la sua vita, dalle relazioni che possiamo e riusciamo o meno ad allacciare.
Le componenti culturali e sociali che le determinano sono multiple, dai territori dove si vive alle condizioni di alloggio, dalla situazione professionale alle attività svolte durante il tempo libero.
Storicamente, il cristianesimo, per più di un millennio e mezzo, ha condizionato la vita delle comunità, e se non vanno separati, esiste una certa differenza tra il sacro e la dottrina, tra i fedeli quali cittadini, e la dottrina, frutto dei Padri della Chiesa.
A riguardo, Agostino, personaggio di spicco che scoprì la filosofia leggendo Cicerone, con ‘Le confessioni’, ebbe un'influenza determinante, in particolare perché confuse il peccato originale e la procreazione.
L'ossessione che lo caratterizzò dopo il suo incontro illuminato con Sant'Ambrogio a Milano (era nato e cresciuto in Africa), ha di che lasciare perplessi. L'amore di Dio per le sue creature, ma soprattutto la perpetua condanna della carne.
Dell'uomo, diceva:
«lui carne e sangue e orgogliosa putredine».
Due temporalità contrassegnano comunque il proposito: la realtà terrena, che attinge alla natura, cicli, riproduzione, evoluzione, fino alla morte, e quella celeste, eternità, cioè assenza di tempo.
Il legame che le associa può risultare trascendente, o semplicemente rituale.
Spesso, si ritiene che la famiglia patriarcale, fosse il frutto esclusivo di costrizioni dettate dalla religione. Sarebbe errato crederlo. La storia della famiglia c'insegna invece che questo tipo di raggruppamento, da un lato non fu attuato senza le diverse strutture economiche necessarie, dall'altro, predominò nella forma oggi conosciuta e contestata soltanto, tardivamente, nell'Ottocento. Finché l'egemonia dell'aristocrazia si esercitò, difficilmente mezzadri e domestici poterono pretendere una struttura autonoma.
Il passo compiuto negli ultimi decenni scaturisce però da un altro procedimento: l'idea di una dinamica sociopolitica che riposasse su movimenti collettivi, anche eventualmente limitati a una coppia in formazione, è stata sostituita da un culto dell'individuo poco definito, particolarmente enfatizzato dalle sceneggiature hollywoodiane e genericamente dal mondo dello spettacolo e dai media. La narrativa dominante, serve un pasto veloce, che loda la libertà individuale e l'assenza di ostacoli. Ognuna a modo suo, l'America e la Francia, (le loro ragioni storiche e ideologiche tra Dichiarazione di Filadelfia e Illuminismo e non mancano), vantano il superamento di ogni intralcio che potrebbe opporsi alla realizzazione di sé.
In un articolo precedente (‘La freccia di Cupido’), citavo Francesco Alberoni (‘L'erotismo’, 1986):
«L'erotismo si presenta sotto il segno della differenza. Una differenza drammatica, violenta, esagerata e misteriosa».
Perché rivolgersi all'erotismo, in un'epoca in cui primeggiano scienza e tecnologia, e sopra di esse, il razionalismo?
Dobbiamo ignorare che l'amore e la sessualità, collegati o separati, rimangono le principali motivazioni che spingono direttamente o indirettamente l'individuo ad agire?
Ed essi non sono di certo governati dalla ragione, e nemmeno in buona parte, dalla natura.
Il superamento di questo dramma, di questa violenza, Alberoni affermava con forza:
«È la prima volta, nella storia dell'umanità, che donne e uomini si osservano a fondo per capirsi.
Per capire devono identificarsi, assumere il ruolo dell'altro».
Questo drastico mutamento avvenuto negli anni Sessanta che fu chiamato “rivoluzione sessuale”, va tuttavia osservato a due livelli diversi. Da un lato, i fatti, non facili da considerare, dato che se la parola è stata liberata, non significa che restituisca con esattezza l'accaduto e il modo in cui viene vissuto dalle singole persone, dall' altro, perché un perpetuo strombazzare discorsivo in materia, finisce col soffocare le singole voci.
Vi sono però alcune statistiche che destano certi dubbi. Per esempio, tra i vari istituti di sondaggio e studi di psicologia, il tradimento concerne tra il 50 e il 70% delle persone, con una differenza notevole tra maschi e femmine. L'uomo tradisce di più, asserzione dubbia sul piano logico, dato che l'epoca in cui il maschio borghese passava le serate nei salotti di una casa d'appuntamenti mentre la moglie si rifugiava nel boudoir, è superata, sebbene la nozione stessa di tradimento venga ristretta a qualunque relazione sessuale al di fuori della coppia. L'esclusivo riferimento a questo tipo di considerazione non è molto significativo. Tutt'al più, indicherebbe quello che asseriscono tutte le culture dagli albori della vita sociale, che l'uomo è propenso a vantarsi e la donna a nascondere, ammesso che lei non debba addirittura tacere. I motivi al riguardo rimangono incerti.
I vari studi consultati sembrano accontentarsi di dati contabili, di un'economia casalinga o collettiva, che dice ben poco.
L'uomo, come la maggior parte degli animali, non sarebbe adattoo alla monogamia. È probabile, senonché, risponde a una cultura più che non a un istinto.
Ma tale riduzione della vita amorosa e sessuale a mero grafico corrisponde abbastanza bene alle attuali considerazioni, non tanto su un tema o l'altro, quanto sugli umani stessi, femmine o maschi.
Questo approccio pone un'altra domanda, fondamentale: la verità, fin dove è giusta da dirsi, o da celare?
Alberoni scrisse:
«Nelle centinaia di libri americani sull'amore, l'innamoramento, il sesso, l'erotismo, non c'è mai una sola pagina dedicata alla menzogna, al riserbo, al non dire, al silenzio, alla dissimulazione. Dovunque, sempre, in ogni caso, si suggerisce, si raccomanda, si impone di dire la verità, tutta la verità, senza nulla nascondere».
Questa utopia, la chiamava ‘religione della verità’.
Potremmo dire ‘confessionale perpetuo’, cioè un atteggiamento che rimanda al peccato.
La constatazione è tanto più sorprendente che nelle serie televisive statunitensi, non manca mai qualche figlio illegittimo, frutto dello stesso peccato probabilmente, ovvero della stessa confusione.
Se riflettiamo seriamente e sulla base delle nostre esperienze proprie alla verità, tutti sappiamo che risulta un inganno nel senso che non si riesce mai ad andare fino in fondo al riguardo, è soprattutto uno strumento a doppio taglio.
Affettivamente, che senso ha aprire il cancello del giardino segreto, se non inquinarlo quando non si è attenti a proteggerne gelosamente alcuni aspetti, non che siano inconfessabili, ma perché ci costruiscono come persone.
Chi ha provato a dire la verità fino in fondo sa che prima, forse ben prima di arrivarci, è impossibile saperlo, l'amore così come il desiderio si sciolgono nei tormenti abissali dell'oblio di sé e del misconoscimento dell'altro/a.
Perduto per sempre il dialogo?
Probabilmente, i tentativi iniziali che segnarono i primi anni della rivoluzione del costume, sono stati affogati in un'interminabile e sostenutissima minestra ideologica incoerente, in cui il verbo ha sostituito la presenza e di conseguenza le sensazioni, l'affermazione sfrenata dell'individuo, lo scambio, le teorie varie, la coscienza personale.
Jacques Lacan diceva:
«‘Amare’, è dare quello che non si ha».
Quell'ignoto che risiede in ogni amore, non lo si può esporre in piazza, mentre la piazza, forse da sempre, desidera l'amore, ma ne diffida.
E la piazza non apprezza il dialogo; preferisce il baccano.