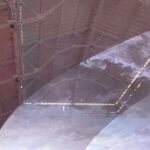L'amicizia ha subito un'evoluzione significativa nella società contemporanea. Un tempo era sinonimo di valori come lealtà, sostegno reciproco e condivisione profonda, oggi appare influenzata da dinamiche sociali, economiche e tecnologiche. Si tratta di una trasformazione o l’amicizia è diventata un elemento superficiale?
Fin dai tempi antichi, tutti hanno analizzato l’amicizia, cercando di interpretarla. Aristotele, ad esempio, nell' “Etica Nicomachea”, distingue tre tipi di amicizia: quella basata sull'utile, quella sul piacere e quella virtuosa, fondata su stima reciproca e condivisione di valori. Solo quest’ultima descrive un rapporto indissolubile e sincero, mentre le prime due definite da lui stesso “accidentali” variabili, si fondano rispettivamente sul divertimento e sul bisogno di raggiungere qualcosa. La riflessione è molto attuale, infatti molti rapporti amicali di oggi soddisfano vantaggi o esigenze personali, invece quelli autentici sono ben pochi e spesso si tende a rimanere soli per evitare delusioni.
Michel de Montaigne, filosofo, (1533-1592) nel suo saggio “De l'amitié”, descrive l'amicizia con il collega Etienne de La Boétie come indistruttibile, fondata su un'intesa quasi mistica e parla delle varie tipologie di amicizia, stabilendo le linee di confine per non perderne il vero senso. Nel mondo contemporaneo invece, i rapporti sembrano sempre più volatili e condizionati dall’occasione di capire quale amico potrebbe portare maggiori vantaggi.
Le amicizie nate sui social network, ad esempio, possono svanire con la stessa rapidità con cui si formano, ma ormai sembra quasi una cosa normale.
Parallelamente, il mercato del lavoro ha reso l’amicizia una risorsa opportunistica. Quante relazioni personali si sviluppano solo per fare carriera od ottenere un beneficio? Quante rimangono salde, perché lavorando nello stesso ambiente è meglio avere alleati, come se dovessimo fare chissà quale battaglia?
Tuttavia, esistono ancora amicizie autentiche, che superano gli anni, i cambiamenti e la lontananza, evolvendosi sempre in qualcosa di nuovo e forte. La domanda da porsi è se preferiamo accontentarci della versione più comoda e superficiale dell’amicizia.
A volte, per quanto fingiamo di lamentarci dicendo di non voler rimanere soli, ciò che vogliamo è l’esatto contrario: l’amico serve per uscire e sfogarci, non per condividere passioni, impegni e non abbiamo né voglia né tempo di farlo lasciando che la superficialità prenda il sopravvento sulle relazioni autentiche.
Tuttavia, la rivoluzione digitale ha ampliato le possibilità di creare e mantenere amicizie, introducendo inoltre nuove dinamiche di interazione. Secondo la sociologa Sherry Turkle, le nuove tecnologie hanno reso le relazioni immediate ma meno profonde: il numero di “amici” sui social network non corrisponde necessariamente alla qualità del legame affettivo che realmente possediamo.
La facilità di entrare in contatto con gli altri si accompagna a una crescente approssimazione. Spesso questi rapporti digitali sono interazioni fugaci, prive di un reale coinvolgimento emotivo. Rispondiamo a foto e stories sui social solo per seguire la massa, fingerci interessati e risultare perfetti, senza difetti.
Le relazioni non vengono più costruite con pazienza e dedizione. Come direbbe il sociologo Zygmunt Bauman (1925-2017) ci ritroviamo in una “società liquida”, dove le relazioni umane, incluse le amicizie, diventano sempre più instabili e asservite a uno scopo pratico, non di autentica partecipazione e condivisione. Nella quotidianità, molte persone si ritrovano a gestire rapporti che si interrompono alle prime difficoltà. Il dialogo è uno scambio veloce, a volte vuoto, e la costruzione di un legame profondo sembra vittima inerme di velocità ed efficienza comunicativa.
Eppure, se utilizzata con consapevolezza, la tecnologia può rappresentare un’opportunità per rafforzare i legami esistenti e creare spazi di condivisione tangibile.
Il rischio è che, nella società contemporanea, si perda la capacità di coltivare relazioni autentiche, con tempo, presenza e dedizione. Se un tempo, per avere un momento di connessione con un amico lontano, si ricorreva a carta e penna, scrivendo e chiedendo senza filtri né censure perché si attendeva pazientemente, speranzosi, questa connessione lenta e fatta di pause costanti è ormai sostituita dalla tecnologia. Oggi, invece, possiamo inviare un vocale, un WhatsApp o chiamare, ma spesso non troviamo il tempo per chiacchierare o dedicare due minuti alle persone a cui vogliamo bene. Eppure, continuiamo a credere che questa mancanza di tempo sia solo un problema tecnologico, o siamo noi che ci siamo spenti nella superficialità delle cose?
Il passato ci manca un po’. Ammettiamolo, abbiano nostalgia di quei rapporti semplici e di quelle amicizie sincere fatte di scambi quotidiani con una piccola cerchia di persone del paese. Certo, erano amici che ci tenevamo buoni per lo più perché non potevamo cambiarli e quindi passavamo sopra le incomprensioni pur di continuare ad avere una vita sociale piuttosto dinamica. Però, erano rapporti veri, reali e non distanti come quelli che la tecnologia sta creando. Anche la famiglia era molto più importante di come viene concepita oggi, in cui quasi nessuno ha rapporti veri con i propri parenti, ma ci si scambiano solo sorrisi di circostanza e ci si incontra quasi per obbligo più che per piacere di condividere e stare insieme. Anzi, si pensa che il mondo è grande, perciò si può sempre trovare qualcuno di nuovo da considerare amico.
Oggi, l'amicizia assume spesso il carattere di un rituale sociale, più che di un rapporto vero, alimentato dall'opportunismo piuttosto che dalla condivisione di valori. Siamo sicuri di non essere soli? La solitudine può essere anche questa: circondati da persone senza avere nessuno a cui confidare le proprie paure più profonde. Se è vero che tutti sono intercambiabili, è comunque difficile parlare di argomenti delicati con chiunque.
Pierre Bourdieu (1930-2002) nel suo saggio “La distinzione” analizza come le relazioni sociali siano legate al nostro capitale sociale e culturale.
Secondo il sociologo francese, frequentare determinati individui o inserirsi in specifici contesti non è una propensione personale, ma una strategia per rafforzare la propria posizione all’interno della società. L'amicizia quindi diventa uno strumento di classificazione. Molto spesso, le relazioni sono costruite rispondendo alla domanda: “Chi può essermi utile?”.
Quali benefici posso trarre dal rapporto? I social esaltano ancora di più tale dinamica: far foto con l’amico benestante permette di mostrare un contenuto adatto a chi vuole mettere in luce il proprio status. Tuttavia, vi è un paradosso: più le amicizie diventano strategiche, meno sono relazioni reali.
Se l’interazione è guidata esclusivamente dall’interesse, i rapporti diventano effimeri e superficiali, e si rimane comunque soli.
Tuttavia, se da un lato i legami deboli offrono vantaggi pratici, dall’altro pongono interrogativi sul significato autentico dell’amicizia. In un contesto in cui le relazioni sono sempre più funzionali e collocate all’utile, le amicizie profonde e disinteressate rischiano di diventare un’eccezione piuttosto che la norma.
La società contemporanea sembra prediligere la quantità alla qualità, ma a quale prezzo?
Se la rete di contatti si espande senza che vi sia un reale senso di appartenenza e fiducia reciproca, l’amicizia diventa solo una semplice moneta di scambio sociale. Essa però non ha perso del tutto il suo valore autentico. Studi recenti in psicologia sociale, dimostrano che, nonostante l’espansione delle reti sociali virtuali, il cervello umano è strutturato, effettivamente, per gestire un massimo di circa 150 relazioni, di cui 5 amicizie intime, indipendentemente dalle migliaia di contatti sui social. Anche nei contesti digitali, dove l’interazione è costante ma superficiale, il bisogno di relazioni profonde e significative continua a esistere, così come la voglia di costruire un legame vero.
Le amicizie più autentiche resistono al tempo e alle trasformazioni sociali perché si fondano su legami emotivi e valori condivisi, piuttosto che su convenienze o opportunità. Un esempio autentico di questa dinamica si osserva durante momenti di crisi personale o difficoltà: quando si ha bisogno di un supporto reale, non ci si rivolge ai conoscenti occasionali o ai contatti virtuali, ma a quel ristretto gruppo di persone fidate che costituisce il vero nucleo delle relazioni significative.
Questo dimostra che, nonostante la società contemporanea tenda a privilegiare la quantità rispetto alla qualità, il valore dell’amicizia autentica persiste e sfida i tempi e la storia. La sfida è quindi quella di bilanciare l’ampiezza della rete sociale con l’illusione di connessioni infinite e la profondità delle relazioni, delle vere amicizie, sentite e più connesse che mai.
Se da un lato l'amicizia sembra essere diventata uno strumento di facciata o convenienza, dall'altro esiste ancora uno spazio per rapporti di valore, basati su fiducia e condivisione, ma soprattutto sull’aspettativa del bello. Forse, più che una crisi dell'amicizia, stiamo assistendo a una sua ridefinizione, in cui la qualità spicca su apparenze e convenzioni sociali.
In un momento in cui l'amicizia sembra sempre più frammentata tra compromesso e convenienza, resta un nodo centrale della nostra esistenza: il bisogno di autenticità, dello schietto. Possiamo avere centinaia di contatti sui social, coltivare legami di facciata per convenienza, ma alla fine contano solo quelle poche persone capaci di restare accanto a noi senza tornaconto, anche quando si è disconnessi.
Se il capitalismo delle relazioni ha trasformato l’amicizia in una moneta di scambio, il valore di un legame autentico è diventato ancora più prezioso, quasi rivoluzionario.
È nella reciprocità disinteressata, nella capacità di esserci senza calcoli, che si misura la profondità di un rapporto. Forse la sfida più grande del nostro tempo è imparare a riconoscere connessioni vere, coltivarle con lentezza e proteggerle dal rumore assordante di una società che confonde la quantità con la qualità. Non permettiamolo.