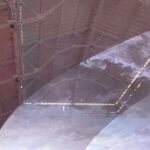C’erano una volta le bambine e i bambini che giocavano incustoditi. Senza lo sguardo dei genitori, provavano la loro riservatezza, solitudine, e l’assoluta esperienza.
Eccezionali spazi e tempi fuori del controllo, e della custodia di qualsiasi istituzione. Custodia è una parola che racchiude protezione e cura, con l’intento di offrire in cambio il preservare dai pericoli. Quali pericoli? Quelli dell’esperienza pura, con la quale mettiamo alla prova la nostra esistenza. Esperiamo, esperimentiamo, proviamo. Con la scopertura della custodia, ci esponiamo a sua vastità l’esperienza.
Le prove dell’incustodito non sono avvertite come pericolose da chi le sperimenta, proprio come Mister Magoo, quasi cieco nelle sue avventure vertiginose, che non si accorge di nulla e senza che nulla gli succeda. Magoo sempre incolume. E la sua incolumità coincide con l’inconsapevolezza, che rende possibile l’esperienza stessa.
Nonostante non consiglierei di agire così, tuttavia non vorrei impedire a nessuno di camminare inconsapevole su quei baratri spalancati, in equilibrio.
Ho fatto esperienza dell’incustodito quando ho preso la barca di mio padre e con un panino e un succo di frutta ho raggiunto il centro del lago di Como, per fare merenda. Anche quella volta che con il motorino ho guidato 60 km per trovare un angolo dove fermarmi a fumare una sigaretta. Oppure quando andavo a camminare nella cava della Falk, dove tutto era fermo, al termine della giornata di lavoro. Avevo tra i 13 e i 14 anni.
Erano momenti in cui nessuno sapeva dove fossi, non informavo nessuno. E il fatto di essere da sola a gestirmi, mi dava tutto il peso della mia presenza stessa, che non era suddiviso, distribuito, e per ciò alleggerito. Ero sola a reggere l’esperienza. Tutta la gravità della mia presenza consisteva nel mio corpo e nella mia anima. E invadeva, occupava ogni angolo, ogni curva di me, senza lasciare vuoti.
Ero in totale intimità con me stessa. Mi sentivo capace. Autorizzavo ogni mia decisione con l’attenzione più squisita. Tutto mi era a portata di mano. Mi fermavo dove volevo fermarmi, e allo stesso modo ripartivo. Potevo ogni direzione: le onde, la strada, il tempo, le osservazioni, le considerazioni. Solo la gioia che affiorassero. E poterle sentire senza alcun bisogno di traduzione da me ad altri, sola nel non-mediato.
Fermarmi qui, svoltare là, bere o mangiare o fumare, come benedizione e sigillo. Io come unica garanzia dell’esperienza. Di tutte le cose in quanto sono o non sono. Autosufficiente e misura. Al centro della mia coscienza intima, conquistata al piacere di pensare autonomamente, composta.
Questi luoghi incustoditi mi hanno insegnato a pensare, e provare il piacere di farlo. Eccitanti stanze tutte per sé, all’interno delle quali, le azioni accadevano poche, nette, ritagliate nella trama del Lebenswelt, vita pulsante e mondo della vita: salire in barca, togliere la copertura, avviare il motore, uscire lentamente dal porticciolo e sentire tra le mani la maestria della manovra, prendere il largo, fermarmi abbastanza lontano e voltarmi a guardare la riva, spegnere il motore, prendere il panino e gustarlo galleggiando sull’acqua verde e scura del lago. Un particolare va al momento dello spegnimento del motore, quando al rombo si sostituiva lo stile dell’acqua, e la prua si abbassava. Non c’era più altro.
E alla cava della Falk, entrare e camminare a macchinari fermi, dismessi da poco, tuttavia immobili, e vasti. E semplicemente entrare, ghiaia ovunque, e polvere.
Così il piacere del ritorno era rendermi agli altri dopo aver acquisito il rapporto a misura perfetta con me stessa. Desiderare gli altri con la stessa pienezza.
Ritornavo, senza bisogno di dirlo, con una sicurezza talmente profonda che non mi chiedevano nemmeno dove fossi stata. E se i miei genitori invece avessero saputo tutto e lo avessero tollerato con pazienza? Non voglio saperlo.